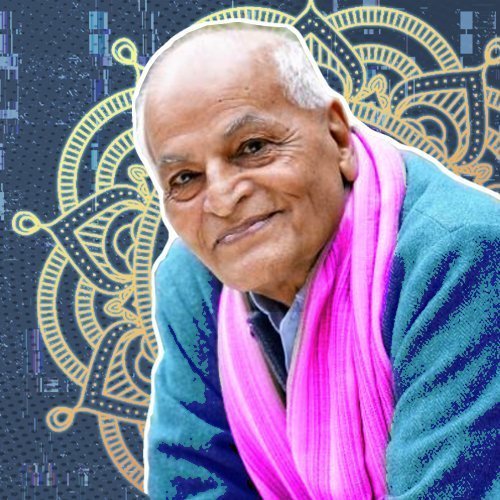La Macedonia è una terra ricca di gastronomia e cultura nel cuore della penisola balcanica. Nel corso del tempo ha subito infatti l’influenza dei paesi confinanti: l’Albania a ovest, la Bulgaria a est, la Serbia e il Kosovo a nord e la Grecia a sud che hanno donato a questa piccola regione grandi peculiarità.
Per secoli l’attuale territorio macedone ha rappresentato un luogo d’incontro-scontro per numerose culture, occidentali e orientali, ottomana ed europea in primis. Ogni passaggio ha lasciato i segni, più o meno marcati ma sempre importanti. I vari influssi gastronomici hanno forgiato l’attuale identità della cucina macedone, una ricca e curiosa alchimia tra Medio Oriente, Paesi balcanici e Mediterraneo.
La cucina delle Tavole Accademiche ha ospitato 4 membri della comunità macedone piemontese, che hanno ideato e cucinato un pranzo dimostrativo delle loro tradizioni. Un modo particolarmente apprezzato per degustare un assaggio di un ricco bazar di sapori che sta iniziando a farsi conoscere cautamente anche in Italia.
Nell’ultimo decennio sono molti i macedoni costretti all’emigrazione per motivi economici che hanno trovato lavoro nel territorio italiano. Altrettante sono le storie di immigrazione e nuove vite italiane, sempre e comunque legate alla terra d’origine.
Ivana Lleva ha lasciato il suo paese appena maggiorenne, con appresso un bagaglio culturale totalmente diverso da quello dei coetanei con la quale ha dovuto condividere la sua nuova vita. Ora Ivana di anni ne ha 28, si sente italiana, ma il suo cuore è rimasto macedone: sente ancora molto vicine le tradizioni della sua terra, in particolare quelle gastronomiche.

L’amore per la cucina lo deve al nonno, cuoco in un ristorante locale, ma critico commensale della tavola famigliare. “La cucina casalinga era il regno della nonna” racconta Ivana, “il nonno ne criticava sempre i risultati ma, sebbene sapesse e amasse cucinare, non ha mai preso il suo posto tra i fornelli. Nonna cucinava, lei mi ha trasmesso molto, ma le critiche del nonno erano vere e proprie lezioni”.
Gli studi di Ivana hanno trattato poco e nulla di cucina (si è laureata in Scienze della Comunicazione a Torino), ma il mondo del cibo e della convivialità è sempre stato parte integrante del suo percorso. Per anni ha lavorato nelle sale di vari ristoranti della zona di Alba e Monforte in veste di cameriera, a contatto con la popolazione locale e non.
Tra una portata e l’altra, conoscendo e chiacchierando con i clienti, ha realizzato che le vigne monfortine parlano macedone. Ha avuto cosí l’idea di scrivere la sua tesi di laurea riguardo alla produzione del vino in Piemonte in relazione alla migrazione macedone. Un approfondimento estremamente interessante e proficuo.
Lavorando alla stesura dell’elaborato, ha iniziato a conoscere più a fondo la comunità immigrata della zona, in particolare i ragazzi, per la maggior parte provenienti dalle aree macedoni più rinomate per l’agricoltura. Il loro cordone ombelicale con la madrepatria non si è spezzato, proprio come quello di Ivana e della sua famiglia; sono molti i prodotti quali riso, fagioli, peperoni, tabacco, che la comunità macedone continua a importare in Italia per uso personale, per rivivere nelle proprie case le emozioni trasmesse dai sapori autentici di casa.
L’interesse di Slow Food per la comunità macedone è in continua crescita, specialmente nell’ultimo anno. Una piccola delegazione ha partecipato attivamente al Terra Madre Giovani a Milano con i propri progetti. Il presidente di Slow Food Macedonia sta puntando sulla comunità immigrata piemontese per alzare il tono della “voce macedone”, ancora troppo lieve e poco considerata. Eppure di cose ne ha da dire.
L’agricoltura tradizionale è senza di dubbio l’attività principale, ma vi è anche una profonda tradizione legata all’allevamento. La cucina è speziata, dai sapori marcati, dai tempi lenti. Spiccano le cotture lunghe e le ricotture delle carni, interpretate in innumerevoli ricette, accompagnate da un egual numero di salse.
Ivana racconta che sono tante le differenze con la cucina italiana: la tavola ad esempio è vissuta come un insieme in cui non esistono portate, ma solo pietanze da condividere contemporaneamente in tavola. Il benvenuto agli ospiti viene dato con un bicchierino di acquavite di prugne o d’uva (rakija), accompagnato da un’insalata di cetrioli, pomodoro e formaggio (shopska). Questo superalcolico è prodotto in ogni casa per il solo uso familiare, non esiste un vero e proprio mercato della bevanda. Non appena i commensali sono pronti a iniziare il pasto, tutte le carni, i pani e le salse vengono portati in tavola allo stesso momento, insieme al vino, solitamente rosso, che si dice sia il migliore dei Balcani.
Il ricordo della domenica in famiglia è un’emozione che scalda costantemente il cuore nostalgico di Ivana. “La domenica si andava a mangiare nella casa in campagna del nonno dove a cucinare era la nonna. D’inverno era ancora più bello, tutto il paesaggio si ricopriva di neve e io non vedevo l’ora di giocarci in mezzo con i cugini. Stavamo ore fuori a scatenarci ma poi, non appena il freddo si faceva pungente e insopportabile, correvamo tutti sporchi, tremanti dentro casa. Non appena si entrava bastava un attimo per far svanire tutto il freddo grazie al calore creato dai fornelli accesi per ore. Mamma era sempre pronta ad accoglierci in fretta per spedirci a tavola dove tutti ci aspettavano: il nonno e lo zio sedevano già allegri con le guance rosse per la grappa e si sentiva un gran vocio di vispe chiacchiere femminili di sottofondo. Avevo freddo e fame, ma non appena la nonna sbucava dalla cucina con le patate dell’orto, i fagioli e tutte le altre pietanze, qualsiasi sensazione svaniva e rimaneva solo una gran gioia, indimenticabile, ancora adesso confortante al solo pensiero”.
Un altro grande regalo piacevole della nonna di Ivana era il Tulumbi, pasta fritta dolce inzuppata in uno sciroppo di zucchero. “Quello di nonna era talmente buono che non si poteva rinunciare a nemmeno un morso dell’enorme dessert. Ma c’era una controindicazione: una volta consumata l’abbondante porzione, si provava quasi un senso di nausea verso qualsiasi cibo dolciastro per i tre giorni successivi a causa dell’esagerata dose di zuccheri assunta in un colpo solo!”
Sempre la stessa nonna ha deciso quando era giunto il momento per la ragazza di assistere alla sua prima vera lezione seria di preparazione di Burek: “Fino a ora hai sempre e solo guardato, ora devi mettere le mani in pasta, crescere, diventare donna”. Mentre emetteva la sentenza la nonna già aveva tra le mani attrezzi e grembiule.
“In Macedonia imparare a preparare il Burek è una sorta di rito d’iniziazione per le ragazze mature”, spiega Ivana, “il Burek è un pane ripieno formato da strati di pasta sfoglia sottilissima e strati di ricotta, carne, porri e ingredienti vari. A descriverlo e a vederlo sembra semplice da preparare, una torta salata quasi, ma in realtà la sfoglia è particolarmente delicata e non tutte le donne riescono a impastarla. Richiede non solo tecnica, conoscenza e ingredienti, ma anche mani adatte, talento. A mia mamma non riesce, eppure segue le preparazioni impeccabili di mia nonna da circa trent’anni; abbiamo scoperto da chiacchiere di paese che molte donne sono come lei: seguono la ricetta, la impastano, ma nulla, si attacca, non viene. Mia zia al contrario cucina un Burek perfetto. Si dice che quando una ragazza impara a cucinare il Burek è pronta per sposarsi. Per questo motivo mia nonna ha voluto che iniziassi a familiarizzare con la pasta quest’estate. Ho sorpreso me stessa e tutta la famiglia. È stato quasi semplice: mi sono seduta a terra a ginocchia piegate con il tradizionale tavolo di legno poggiato sulle gambe e ho iniziato a stendere, stendere, stendere e appallottolare la pasta, stendere, stendere, stendere e appallottolare. Le mani mi scorrevano soavemente sul mattarello senza alcuno sforzo, “suonavo” la sfoglia. Mia zia, incredula, ha voluto riprendere la scena per mostrarla con orgoglio in famiglia!”
Nel cuore di Ivana e in quello dei molti suoi connazionali immigrati in Italia la cultura italiana non ha faticato a inserirsi, sebbene la tradizione macedone rimanga la colonna portante delle loro vite. L’adattamento al mangiare-bere italiano è stato piuttosto piacevole, dicono. Così Ivana riporta la sua esperienza: “Amo la cucina italiana e in particolare la carne cruda. Un alimento, questo, che molti miei connazionali non riescono nemmeno ad assaggiare perchè in estremo contrasto con i gusti della nostra terra. Le nostre carni sono stracotte e ri-cotte, quindi non è facile abituarsi all’idea di mangiare carne cruda. Io invece, sarà perchè ho gli orizzonti molto ampi, o semplicemente un gusto diverso, la adoro e la metterei anche nel ripieno del Burek!”
Quando e se Ivana inizierà a cucinare il suo burek “italiano”, arricchirá la cucina macedone di una nuova prelibata influenza, quella italiana. Nuovi ingredienti che probabilmente contamineranno le vecchie tradizioni dando vita a nuove realtà culinarie.