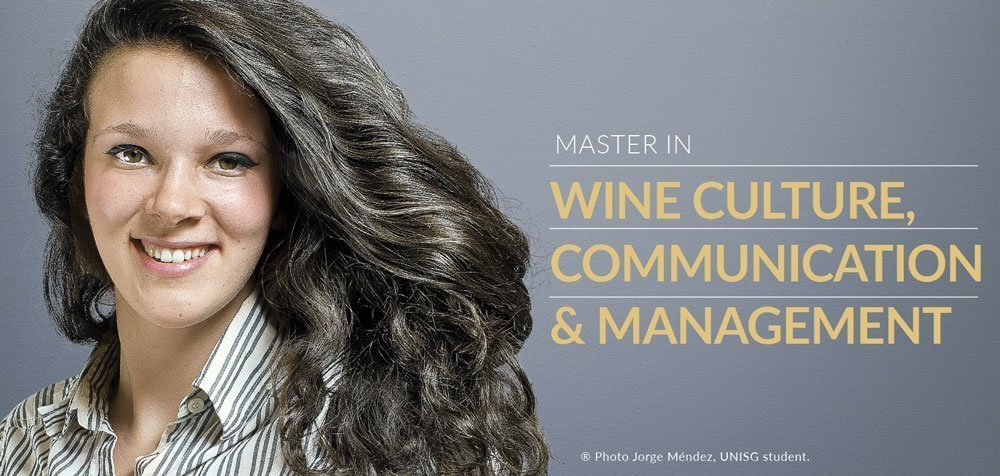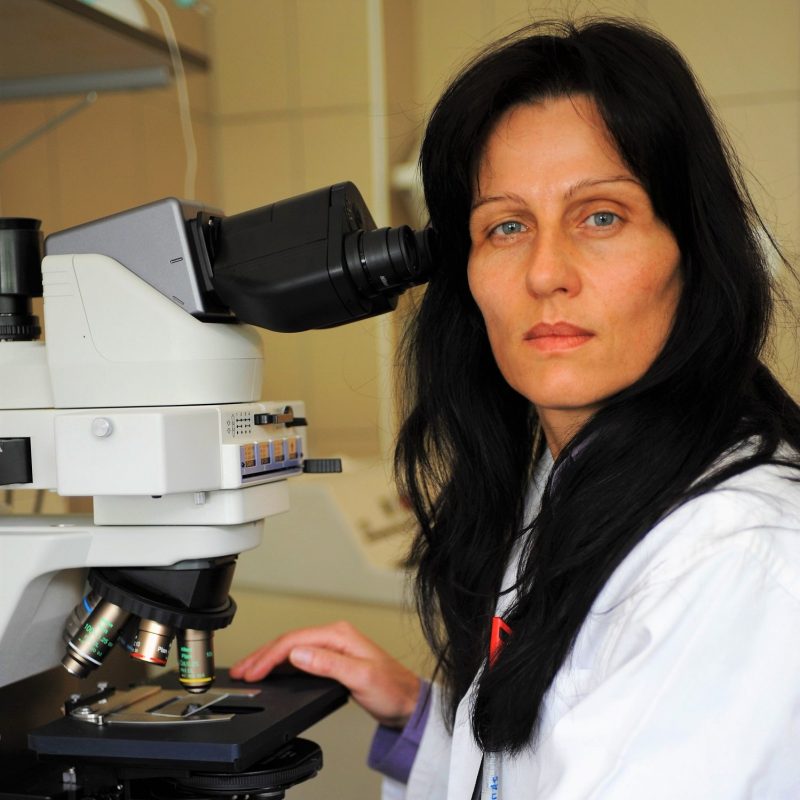Una chiacchierata con Ulrich Fischer, visiting professor dell’Università di Scienze Gastronomiche
Ulrich Fischer è il fondatore e direttore dell’Istituto di Viticoltura ed Enologia nel Weincampus di Neustadt, in Germania.
Dopo la laurea in viticoltura ed enologia presso l’Università di Scienze Applicate di Geisenheim, ha continuato la sua formazione negli Stati Uniti, presso l’UC Davis, lavorando con la prof.ssa Ann C. Noble, un’autorità nel campo dell’analisi sensoriale del vino.
Rientrato in Germania, è entrato a far parte del Food Chemistry Institute di Ralf. G. Berger all’Università di Hannover. Successivamente, ha insegnato tecnologia alimentare e alimentare nel corso di Chimica degli alimenti dell’Università Tecnica di Kaiserslautern, che gli ha conferito una cattedra onoraria nel 2003.
Attualmente insegna scienze sensoriali, chimica del vino ed enologia a Neustadt e tecnologia alimentare presso l’Università di Kaiserslautern.
Lo abbiamo incontrato durante il corso che tiene a Pollenzo all’interno del Master in Wine Culture, Communication & Management per porgli alcune domande.

Come valuta la sua esperienza con gli studenti dei nostri Master?
Ho iniziato a insegnare nella sede UNISG di Colorno nel 2008: il mio focus è sempre stato la tecnologia del vino, ma ho anche insegnato scienze sensoriali e ora sto tenendo un corso sulla Fisiologia del Vino e Potatura nel Master in Wine Culture, Communication & Management.
La cosa più sorprendente dell’insegnamento qui a Pollenzo, così come prima a Colorno, è sempre stata la grande diversità degli studenti che provengono da tutto il mondo: sono giovani entusiasti e interessati ai temi. Ecco perché mi piace molto insegnare qui.
Durante le mie lezioni porto sempre una grande varietà di vino con me, principalmente si tratta di vini sperimentali, in modo che gli studenti non imparino solo dal punto di vista teorico, ma sperimentino, ad esempio, la differenza del vino fermentato spontaneamente rispetto a quello fermentato con lieviti, o una differenza tra un Barolo invecchiato in barrique e uno invecchiato con trucioli di legno.
C’è molto interesse in queste cose ed è molto bello vedere questa passione per il vino, ma anche per la cultura del vino e del cibo e per chi produce cibo e vino.
Che opinione ha dell’Università di Scienze Gastronomiche e i suoi programmi?
Ho avuto modo di conoscere vari corsi e programmi di chimica alimentare e di tecnologia alimentare in tutto il mondo attraverso il mio insegnamento, ma ciò che offre Pollenzo è qualcosa di speciale, perché qui viene messo in pratica un approccio interdisciplinare e non ci si concentra troppo su tecnologie specifiche: qui si insegna la cultura del cibo e tutto quanto ruota attorno ad esso. Si tratta di un progetto didattico unico, che non ho visto altrove finora.
Inoltre, ho notato con piacere un netto miglioramento del corpo studentesco negli ultimi anni. Confrontandomi con alcuni colleghi qui a Pollenzo, ho saputo che oggi ci sono sempre più aspiranti studenti e si può effettuare una buona selezione tra coloro che sono davvero motivati e interessati.
Professor Fischer, come vede il futuro della gastronomia?
Quando parliamo del futuro del cibo, ovviamente la sfida più grande è come nutrire gli 8 miliardi di persone nel mondo: e questo è un problema molto serio.
Allo stesso tempo, in paesi sviluppati come la Germania o l’Italia, possiamo notare il numero crescente di consumatori che non scelgono più cibo e vino a basso costo, ma sviluppano interesse per cibi più autentici e genuini. Quindi, vedo che c’è un trend che fa ben sperare, ma dovremmo comunque ancora concentrarci su come possiamo diffondere la consapevolezza del cibo in quei paesi che hanno ancora problemi nel nutrire la loro popolazione. Dovremmo perciò considerare che non viviamo protetti nella nostra oasi, ma dobbiamo avere una visione globale di questo problema, ed è bello vedere qui a Pollenzo studenti provenienti da Cina, India, Perù, Nigeria, Etiopia, discutere e condividere le loro idee in merito.
Quale potrebbe essere il futuro del vino secondo lei? Un po’ provocatoriamente le chiedo: il vino è un alimento? O uno status symbol? O una bevanda solo per i paesi ricchi?
Il vino non è un alimento dal mio punto di vista, perché contiene un bel po’ di alcool, quindi ha alcuni aspetti negativi: ma è una bevanda culturale, quella che rappresenta meglio la cultura del cibo in tutto il mondo, proprio grazie alla sua ricchezza e diversità. Ne sono convinto!
Oggi vediamo che i paesi in via di sviluppo si stanno interessando in modo crescente al vino e, fortunatamente, le moderne tecniche di vinificazione fanno sì che il vino non debba essere necessariamente costoso.
Quindi, se si considera la produzione totale di vino nel mondo, possiamo calcolare che per ogni abitante del mondo ci sono 5 bottiglie di vino.
Penso che sarebbe bello per chi ama il vino – ovviamente, non considerando quelli che, per il loro credo religioso, non possono berlo – condividere questo vino, perché porta gioia, ci collega con la nostra storia e i con i nostri antenati migliaia di anni fa, ma guarda anche al futuro; prendiamo, ad esempio, la vinificazione in Cina e in India oggi.
È quindi una bevanda culturale, ma non dovrebbe essere una bevanda di lusso; dovrebbe portare gioia a quante più persone possibile.
Cosa ne pensa di questa esaltazione e di questo fervore nella degustazione del vino e nella sua descrizione?
La scienza sensoriale e la valutazione del vino attraverso i nostri sensi colmano il divario tra la viticoltura, la vinificazione, i consumatori e le loro preferenze sul vino. Per me è stato fondamentale essere uno studente di Ann Noble alla UC Davis University e la ringrazio per avermi portato qui a Pollenzo.
Reputo perciò la valutazione sensoriale molto importante per descrivere il vino, in modo che tutti possano capire e seguire.
Certo, ci sono alcuni giornalisti e alcuni produttori di vino che usano terminologie sussiegose e fanno un po’ di scena intorno al vino. Detto questo, io penso che sia fantastico poter parlare di vino in un modo comprensibile a tutti: così noi democratizziamo il vino. Tutti dovrebbero avere la capacità di parlare della loro passione e del loro piacere.
Ecco perché la valutazione sensoriale è molto importante, a Pollenzo come anche a Kauserlautern e Neustadt, in quanto aiuta a coinvolgere le persone e permette loro di descrivere ciò che provano e sperimentano, anche se sicuramente alcune persone esagerano un po’.
Da un punto di vista culturale, lei ha affermato che il vino è legato alla nostra storia e ai nostri antenati.
Il vino ha caratterizzato inizialmente le aree del Mediterraneo e del Medio Oriente e ora è un prodotto globale. Pensa che ci sia ancora una supremazia europea nella produzione di vino e nella cultura del vino?
No, non lo penso. Il vino è stato inventato in Mesopotamia e prodotto in Medio Oriente. Sicuramente, in Europa abbiamo fatto passi avanti nella produzione del vino nel Medioevo, ma ritengo che il concetto di terroir sia un’interazione del suolo, del clima, delle specifiche tecniche di vinificazione, che sono uniche per un luogo e questo luogo può essere in California, in Cina, in Australia o in altri luoghi ancora.
Io sono una persona curiosa, sempre aperto alle novità e penso che l’antica tradizione del terroir in Europa abbia limitato i top wines a determinate aree, persone e tecniche.
Il mondo è troppo ampio e vasto per limitarci a un luogo specifico: è bello avere questo approccio tradizionale, ma è importante anche il fatto che alcune di queste tradizioni vengano copiate e utilizzate in nuove aree del mondo.
Ora stiamo vedendo sviluppi straordinari di vinificazione in regioni del mondo cui non avremmo mai pensato due secoli fa: sono felice che ci siano grandi vini in diverse regioni del mondo.
C’è una storia particolare sul vino, nella sua carriera di insegnante, che può condividere con noi?
Un paio di anni fa, qui a Pollenzo, ho avuto una studentessa indiana proveniente da una famiglia che possedeva diversi alberghi in India. Durante la mia conferenza ho portato un vino tedesco della regione del Rheingau, conservato in una bottiglia molto originale, simile più ad un flacone di profumo che non una bottiglia di vino. Il vino era un Riesling, che è comune in quella zona.
A questa studentessa piacque così tanto il vino e la sua bottiglia che ne ordinò personalmente una piccola quantità già durante il mio corso: in seguito scoprii dai proprietari della cantina che ora questa signora importa il vino in India. Ecco come, casualmente, si possono creare dei ponti grazie al vino, in questo caso tra l’Europa e l’India: tutto grazie ad una mia studentessa, attratta sia dalla bottiglia che dal vino stesso.
by Alessandra Abbona, UNISG Communication Office